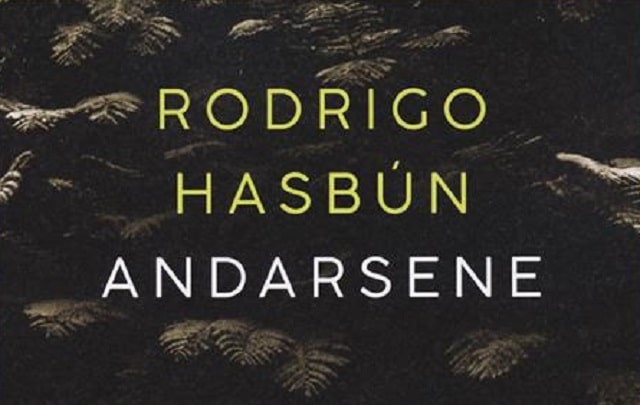Chi conosce da vicino il territorio del delta del Po avrà già confidenza con l’atmosfera spettrale delle valli che Matteo Cavezzali racconta nel suo romanzo Il labirinto delle nebbie, pubblicato da Mondadori.
Chi invece non ha mai attraversato quelle terre bagnate e sabbiose, silenziose e apparentemente infinite, talvolta oscure e spaventose, troverà tra queste pagine paesaggi inaspettati, al limite di un grottesco horror d’altri tempi.
Il labirinto delle nebbie
Siamo nel primo dopoguerra, nella provincia di Ravenna, dove la terra si fonde col mare e le paludi circondando interi paesi che attendono di essere inghiottiti da un momento all’altro.
Siamo poco più in là di quelle terre che già Pupi Avati aveva trasformato in luoghi dell’orrore dando vita addirittura a un genere, il gotico padano da cui appare evidente l’ispirazione di Cavezzali.
Nella Romagna che confina con l’acqua c’è Afunde, un piccolo paese in cui ormai sono rimaste solo le donne, perché tutti gli uomini sono andati in guerra e dal fronte non sono mai tornati.
È lì che un giorno viene trovato il corpo di Angelina, una giovane ragazza malamente sgozzata, e dove viene mandato a indagare da Bologna l’ispettore Bruno Fosco, uomo tormentato e sopravvissuto alla guerra, almeno fisicamente.
Per finire ad Afunde C’erano solo due motivi: o ci eri nato e non avevi avuto la possibilità di scappare, oppure ci arrivavi per nasconderti e scomparire nel nulla.
Ci passavano briganti, anarchici, teppaglia violenta, e ci vivevano contadini imbarbariti, infarciti di superstizioni pagane. Ora una ragazza era stata assassinata e qualcuno doveva pure andarci per mostrare che esisteva ancora una parvenza di giustizia; dopo tutte le inutili morti della guerra, uccidere era tornato illegale. Ci voleva qualcuno non sacrificabile.
Chi ha ucciso così brutalmente la ragazza?
Perché lo ha fatto?
E cos’è quel simbolo che Angelina ha inciso sulla pelle del collo?
Un serpente che si morde la coda, un uroboro, che fin dall’antichità rappresentava tutto ciò che tende all’infinito, senza soluzione di continuità. Che significato avrà in quel contesto non certo elitario ed erudito?
Fosco, per quanto perplesso dalle stranezze di quel paese che pare sprofondare giorno dopo giorno nell’acqua, non vuole soccombere al terrore provocato dal brutale assassinio e dagli strambi personaggi che lo circondano.
A parte il prete, il conte Galanti – padrone del latifondo – e suo figlio, lo storpio e mezzo cieco Tancredi, l’unico altro uomo di Afunde è il vecchio Primo, che dalla guerra ha fatto ritorno portando con sé il peso dell’orrore più vero.
E le donne?
Sono rimaste loro a lavorare la terra, a produrre per far arricchire il padrone, a sgozzare il maiale per farne cibo per tutte e ad allevare i pochi animali che possono vivere in una terra così ostile e insalubre.
Ci sono solo loro a tenere in vita quel paese maledetto.
Tra queste c’è Ardea, che sotto l’aspetto trascurato nasconde una bellezza indomita e focosa ed è madre della piccola Ada, l’unica bambina che Fosco riesca a vedere tra le nebbie e il grigiume del paese.
Ora Ardea era una donna irriconoscibile: gli occhi velati, i capelli arruffati, un disordine che cominciava dall’anima. Rimaneva però in lei il lato indomito che alcuni avrebbero definito selvaggio. Era come un cerbiatto ferito, che non si era lasciato uccidere dallo sparo del cacciatore ma ne portava i segni: era una sopravvissuta. Se la sua fiamma era ancora tale, era perché l’accendeva sua figlia, che la spronava, volente o nolente, verso l’amore.
La spirale di violenza non si ferma e altri delitti avvengono ad Afunde, dove tutto è sempre più confuso e inspiegabile.
Raggiunto da un sottoposto che dovrebbe aiutarlo, Bruno Fosco si rivolge anche a Primo e insieme cercano di fare luce sul mistero che avvolge quel luogo abbandonato da dio e dagli uomini.
Qualcosa di più grande di loro, però, li metterà di fronte ai ricordi del passato, a quei mostri che vivono nelle loro menti, a quel destino da cui già una volta sono sfuggiti.
«Ogni respiro, ogni istante in cui siamo vivi è un dono che rubiamo alla morte. Non il contrario. La morte non ci porta via nulla, perché noi siamo già cosa sua. Siamo noi che possiamo rubarle ogni mattina una giornata di vita. Noi siamo una parte del cosmo. Non dobbiamo pretendere di capire ogni cosa, perché non possiamo. Possiamo aspirare però a capire dove stare.»
Cavezzali dettaglia con attenzione l’atmosfera maligna che incombe su Afunde, vera protagonista de Il labirinto delle nebbie, mentre trascura e pennella fin troppo velocemente i tormenti degli uomini e delle donne, che qui sono solo pedine in un mondo in cui a dominare sono la natura e l’istinto primordiale che muove verso la sopravvivenza.
Qualche pagina in più – che approfondisse i perché di certe azioni confuse e difficilmente spiegabili e che desse un senso ai simbolismi appena accennati ma evidentemente necessari a rendere più incisiva la trama – avrebbe certamente giovato a una storia che può, nonostante la fretta e le mancanze, ritagliarsi un angolino nell’immaginario di lettori e lettrici, come una vecchia e spaventosa leggenda che si tramanda di generazione in generazione.
L’epilogo, narrato dalla voce personale dell’autore e quindi decisamente accattivante, riscatta quella sensazione di incompiutezza che aleggia su buona parte delle pagine precedenti.

un libro per chi: cerca una lettura non troppo complessa da fare di notte, nell’oscurità
autore: Matteo Cavezzali
titolo: Il labirinto delle nebbie
editore: Mondadori
pagg. 175
€ 19